La promessa, Friedrich Dürrenmatt, Adelphi, 2019
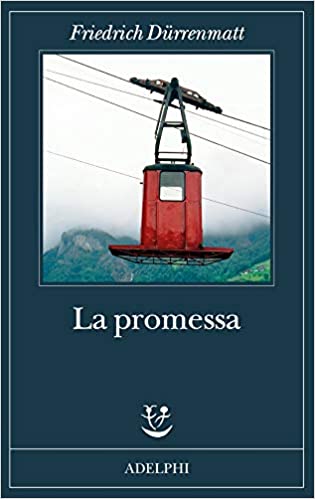
Quando ho iniziato a leggere La promessa di Friedrich Dürrenmatt, pensavo che avrei faticato a non immaginarmi il protagonista con le rughe sregolate di Jack Nicholson e le atmosfere dell’adattamento cinematografico di Sean Penn, ma mi sbagliavo: lo scrittore svizzero non ci ha messo molto a farmi capire che avevo di fronte qualcosa di diverso.
Come è successo con Non è un paese per vecchi, sono arrivato al romanzo dopo il film, ma se i fratelli Coen sono riusciti nell’impresa di riempire gli spazi tra le parole di McCarthy, nel caso de La promessa, il film del 2001 è alleggerito di tutta una componente metafisica molto presente invece tra le pagine di Dürrenmatt.
Al di là dei più o meno dannosi cambi di retroscena e ambientazione, la pellicola, a causa di un’importante omissione di una parte della storia, viene resa in un qualche modo più digeribile, come se Sean Penn non volesse far troppo male allo spettatore, allo stesso modo di un buon padrone di casa che, attento alla glicemia dei suoi ospiti, si preoccupa di fargli trovare sulla tavola una più dietetica Coca Zero.
Scritto inizialmente come sceneggiatura del film Il mostro di Mägendorf, La promessa, recentemente ripubblicato da Adelphi, con la traduzione di Donata Berra, fin da subito, complice anche il sottotitolo Requiem per il romanzo poliziesco, palesa le sue intenzioni: un J’accuse al genere che, a suo modo, lo ospita.
È il narratore, un ex comandante della polizia a mettere le mani avanti, rimproverando a uno scrittore in visita, che ha appena tenuto una conferenza sul romanzo giallo, i cliché narrativi adottati e abusati nel filone delle “celluline grigie”, ricordandogli come la banalità di tutti i giorni, a volte, sia più creativa di certi archetipi narrativi.
“(…) − Un mondo simile può anche essere perfetto, d’accordo, però è una menzogna. Lasciate perdere la perfezione se volete progredire verso le cose, verso la realtà, come si addice a degli uomini; altrimenti statevene lì a baloccarvi con i vostri inutili esercizi di stile. −”
La struttura narrativa è, a tutti gli effetti, quella del romanzo giallo-poliziesco. C’è un cadavere ritrovato e un presunto colpevole facile da sospettare. Ci sono le comode deduzioni di certi poliziotti e tanto tabagismo. C’è anche il geniale investigatore che indaga per conto proprio, ma Dürrenmatt ha dei piani diversi per il suo protagonista, d’altronde, come dice il comandante della polizia a riposo che racconta la storia allo scrittore: “Niente è più crudele di un genio che inciampa in un’idiozia”.
Nel romanzo troviamo lo stesso trattamento fatto da Eastwood, diversi anni dopo, per il western, nel film Gli spietati. Una sorta di raschiamento dell’epica che posiziona l’opera come un grosso punto in fondo alla frase, un punto da cui si può solo andare a capo, da cui il genere di riferimento può solo rinascere o morire definitivamente.
Se nel capolavoro del vecchio Clint i cowboy sono più impegnati a combattere prostatiti da galoppo notturno o a sfidare l’artrite invece che intraprendere assolati duelli o fughe a cavallo, ne La promessa il geniale investigatore non arriva alla soluzione del delitto dopo una serie accurata di colpi di genio, ma, un colpo di genio dietro l’altro, impazzisce, nella ricerca di un assassino che potrebbe anche non esistere.
Dalla voce dell’ex comandante di polizia seguiamo il capitolare in un abisso di follia tanto lucida quanto spietata di quello che fino a poco prima era il più brillante detective del distretto, il commissario Mätthai.
In seguito alla promessa fatta alla madre della vittima di trovare l’assassino della bambina uccisa a colpi di rasoio e non convinto della colpevolezza del solito venditore ambulante di rasoi passato di lì per caso, Mätthai decide di rinunciare a un posto d’oro come supervisore della polizia locale in Giordania, per mettersi sulle tracce del vero colpevole. Dapprincipio la determinazione di Mätthai sembra mossa dal dovere morale nei confronti della promessa, per impedire il ripetersi di un dolore simile, ma, pagina dopo pagina, tentativo dopo tentativo, più l’ex commissario si ostina a risolvere con la logica l’indagine più perde la ragione, ma è con ragione che, pur di mantenere la parola data, arriva ad escogitare azioni eticamente ambigue, perché “Mätthai non molla mai”, ripete del resto il narratore. Come nel passaggio, che farebbe invidia anche all’Haneke più ispirato, dove Mätthai, dopo aver dato alla sua indagine un’impronta venatoria, sente che la preda sta per abboccare, che forse non è così pazzo come dicono, che una preda da catturare esiste realmente, e non ci pensa due volte a lanciargli in bocca l’esca, anche se la sua esca è una bambina di aspetto simile alla vittima.
“− Te le ha date il mago? −
La bambina taceva.
− E ti ha proibito di raccontare di voi due? − chiese ancora Mätthai.
Nessuna risposta.
− E tu non farlo − disse lui con gentilezza. − Quello è un mago buono. Torna pure da lui anche domani −.”
Con una prosa asettica, Dürrenmatt, capitolo dopo capitolo, aggiunge elementi per trovare una variabile che ha come unico risultato l’incognita stessa, nella sua indeterminazione, nell’incapacità di arrivare a una giustizia oggettiva e risolvere le infinite equazioni del caso, tematiche tanto care all’autore.
Forse, se dietro la macchina da presa per dirigere l’adattamento cinematografico ci fosse stato il regista di Niente da nascondere e Il nastro bianco, la vicenda si sarebbe svolta in un ridente paesino austriaco, e non comunque in Svizzera, ma sicuramente un provocatore come lui non si sarebbe fatto scappare una delle più emblematiche frasi del libro: “Non si può credere con quanta imprudenza le mamme vestano le loro figlie”.
[Immagine di copertina: Gas, Edward Hopper, 1940]

