Visioni di contrabbando. Il cinema inarrestabile di Jafar Panahi, di Claudio Zito, Digressioni editore, 2020
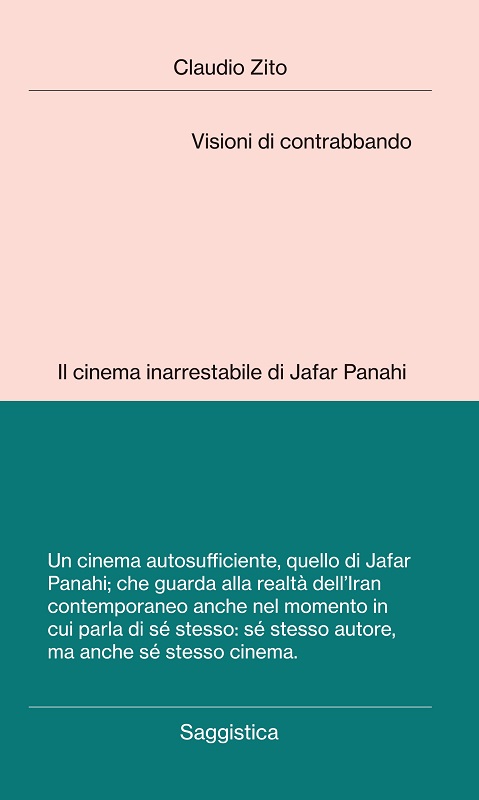
Questa estate torneremo a viaggiare, dentro e fuori dalle regioni, in lungo e in largo su quasi tutto il globo terracqueo, e questo dopo 14 mesi di sedicenti lockdown (solo quello di marzo 2020 si avvicina all’esperienza di chiusura totale messa in atto in Cina) in cui lo spazio intimo, privato è tornato a essere protagonista indiscusso della vita delle persone. Per il regista iraniano Jafar Panahi, invece, il 2020 ha rappresentato il giro di boa di un confinamento più subdolo, conseguenza di un processo sommario a causa del quale, oltre a non poter lasciare il paese se non per andare in pellegrinaggio alla Mecca o per cure mediche, non può girare film, scrivere sceneggiature e rilasciare interviste.
Ma andiamo con ordine seguendo lo sviluppo del bel saggio di Claudio Zito che, forte dell’esperienza tutt’ora attiva del blog Cinema Iraniano, approccia la vita e la carriera di uno degli autori fondamentali della contemporaneità in senso cronologico, dedicando a ogni film una scheda tripartita sinossi/critica/curiosità. Panahi nasce come autore televisivo, si forma all’interno di una scuola di cinema e poi esordisce sul grande schermo nel 1994 grazie al nume tutelare del cinema mediorientale moderno, Abbas Kiarostami, sul set di Sotto gli ulivi , terzo e ultimo capitolo della “Trilogia Koker” (dal nome della città dove è ambientata). Il suo ruolo è aiuto-regista, ma siccome Kiarostami sta girando uno degli esperimenti più riusciti di meta-cinema, a Panahi tocca anche interpretare se stesso in una sequenza cruciale; ci piace infatti pensare che quel “Mr. Panahi!” pronunciato da Kiarostami durante un’invasione di campo, segni il passaggio di testimone tra maestro e allievo.
Una volta divenuto regista il suo sguardo si abbassa inizialmente ad altezza bambino, perché da quella prospettiva riesce a mettere a nudo le contraddizioni del sistema smarcandosi dall’etichetta di “cinema politico”. In questo modo può girare sequenze dirompenti, come nel caso di Lo specchio (1997) in cui la giovane protagonista, circa a metà, decide di non voler più stare dentro il film e fugge dalle riprese: “il gesto di Mina – scrive Zito – va però oltre il gioco metalinguistico. La bambina non getta solo il gesso finto e gli abiti di scena: tra questi c’è l’hijabi, simbolo per eccellenza della costrizione sociale nell’Iran contemporaneo; obbligatorio, a scuola, anche per le bambine”. Avvicinarsi al cuore del paese significa anche camminare sul bordo della legalità, come per Offside (2006) girato semi-clandestinamente fuori da uno stadio di calcio precluso al pubblico femminile, su una sceneggiatura diversa rispetto a quella presentata al ministero per il nulla osta.
Il passo successivo è la condanna di cui all’inizio che, invece di decretare la fine della carriera di Panahi, apre la fase successiva della sua sperimentazione visiva. A questa svolta Zito dedica un intero capitolo, come fosse un film o una meta-narrazione che ci chiede di dubitare (la fuga di Mina dal set è reale o fa parte della sceneggiatura? Il regista è realmente costretto a non girare film per vent’anni?), per poi dedicarsi ai suoi ultimi quattro (non)film “clandestini” e alle ingegnose trovate necessarie per farli arrivare ai principali festival europei. Fondamentale, a questo punto, secondo Zito diventa la leggerezza degli strumenti di ripresa digitale a disposizione di Panahi poiché tale scelta “gli consente di continuare a fare cinema aggirando vincoli, divieti e barriere; di documentare la realtà tenendo anche una sorta di video-diario, virando così verso un cinema di impianto saggistico e verso l’auto-fiction; di minimizzare, infine, i costi di produzione, conservazione e circolazione del materiale”(pag. 71-72). This is Not a Film, Closed Curtain, Taxi Teheran e Tre volti sono le opere prodotte e distribuite dal 2011 al 2018 che possono essere viste come tappe di un progressivo riemergere dell’Io, a partire dalla privazione sensoriale (“sono costretto a tacere, a non vedere” scriverà in una lettera) passando per l’accettazione della condizione di isolamento e procedendo verso la progressiva trasformazione di ogni limite in una sfida creativa. Chissà che effetto farebbe rivedere ora This is Not a Film, e chissà come sarà il cinema di Mr. Panahi quando il suo personalissimo lockdown sarà finalmente terminato.

